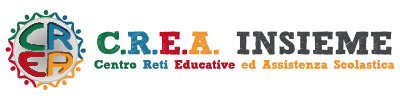Resilienza e Neuroplasticità a scuola
Articolo pubblicato nel sito di Asociaciòn educar il 21 ottobre 2020 e scritto dal
Dott. Guillermo Vuelta
Oggi siamo di fronte alla grande “sfida” di fronteggiare questa pandemia. Ed è una circostanza imbattibile farlo ripensando alla scuola, “reinventandola”. Così possiamo usare tutta la “creatività” che hanno i nostri insegnanti, ma che anche le nostre famiglie hanno dimostrato di doversi sostenere affettivamente ed emotivamente con l’obiettivo di continuare a sopravvivere.
Attraverso questo potenziale creativo che abbiamo come esseri umani, più il contributo delle risorse tecnologiche e l’innata curiosità dei nostri figli, dobbiamo incoraggiarci a fare di più. Mettere al centro l’istruzione, le aule, l’insegnamento e l’apprendimento, ma permetteteci anche di aprirci a un cambiamento che coinvolge l’intera società. Sembra un cliché, ma è una grande possibilità: la nostra resilienza sarà fondamentale.
Neuroplasticità come substrato per la resilienza
La resilienza dal punto di vista della neurobiologia è la capacità di un individuo di adattarsi con successo a stress acuti, traumi o forme croniche di avversità.
È necessario che si verifichi la resilienza che il soggetto ristrutturi l’esperienza negativa, in modo che possa riconfigurarsi dagli elementi della sua esperienza, raccontando un’altra storia con la stessa storia, cioè riorganizzando la memoria. Ciò suggerisce che processi come l’apprendimento, la rappresentazione e la discriminazione del contesto, il consolidamento dei ricordi e i cambiamenti nelle connessioni neurali sono indispensabili per la resilienza.
Il substrato biologico della resilienza è la neuroplasticità, che consente l’integrazione, momento per momento, di informazioni interocettive, esterocettive, emotive, motivazionali e cognitive.
Studi recenti hanno dimostrato che sono implicati i circuiti classici della paura (amigdala), della ricompensa (nucleo accumbens) e dello stress (asse ipotalamo-ipofisi-surrene), e il PFC e l’ippocampo nei substrati neurali della resilienza. È importante notare che queste ultime sono le strutture più sensibili allo stress acuto e cronico, quindi ha senso che siano cruciali nei processi di resilienza. Ciò che è rilevante in questa ricerca è la certezza che la resilienza ha a che fare con la creazione di nuovi ricordi. Ciò richiede la selezione e l’apprendimento di nuove strategie, la risoluzione dei problemi, la rappresentazione del contesto e la riorganizzazione delle reti neurali.
La plasticità neurale, approfondita negli ultimi anni, coinvolge un’infinità di processi strutturali e neurochimici. In quest’ultimo caso, un numero significativo di neurotrasmettitori, neuropeptidi, citochine e ormoni sono coniugati per mediare i meccanismi neurobiologici di resilienza e sono caratterizzati dall’adempimento di funzioni sia biologiche che metaboliche, nonché altre funzioni di condizionamento comportamentale più complesse (ad esempio ricompensa, paura e comportamento sociale).
In sintesi, l’evidenza empirica suggerisce che i determinanti della resilienza sono complessi e includono fattori sociali, psicologici e biologici (genetici ed epigenetici). Nelle persone resilienti, variabili costituzionali, biologiche e genetiche interagiscono con variabili ambientali e comportamenti appresi per risolvere determinate situazioni avverse, evitando o prevenendo un disturbo irreparabile.
Il termine resilienza è una trasposizione della parola inglese resilienza, originariamente usata in termodinamica. Successivamente le scienze biologiche e sociali se ne sono appropriate per descrivere stati di resistenza a esperienze o rischi avversi.
Secondo Anna Forés, Direttore della Cattedra di Neuroeducazione dell’Università di Barcellona, “La resilienza è la capacità di emergere più o più forti di fronte alle avversità. La resilienza non è adattamento, è creatività. Deve esserci una trasformazione ”.
Le neuroscienze ritengono che il cervello sia l’organo esecutivo centrale del sistema biologico responsabile della resilienza e responsabile della regolazione dei meccanismi neurobiologici, cognitivi e psicologici dell’individuo legati alla resilienza.
Bibliografia:
Montes-Rodríguez, C. J. e Urteaga-Urías, E. (2018). Plasticità sinaptica come substrato per la resilienza. Journal of Neurology, 67 (11), 453-460. https://doi.org/10.33588/rn.6711.2018258
Sanchez, E. e Vargas Parada, L. (2019). Come si riprende il cervello: neurobiologia della resilienza. Università Nazionale Autonoma del Messico. Estratto da: https://www.c3.unam.mx/noticias/noticia89.html
Madariaga, J. M. (Coord.) (2014). Nuovi sguardi sulla resilienza. Gedisa.
Forés, A. e Grané, J. (2019). I brutti anatroccoli e cigni neri: resilienza e neuroscienze. Piattaforma editoriale.
Monroy Cortés, B. G. e Palacios Cruz, L. (2011). Resilienza: può essere misurata e influenzata? Salute mentale, 34 (3), 237-246.